
Con il Building Information Modeling (BIM) si è aperta la strada verso nuove opportunità professionali per i tecnici, ridefinendo ruoli e responsabilità nel settore delle costruzioni.
Architetti e Ingegneri, infatti, stanno ridefinendo i propri ruoli professionali, assumendo nuove funzioni di consulenza, formazione e supporto alla pubblica amministrazione, contribuendo all’innovazione e all’efficienza dei processi progettuali e gestionali.
Un processo reso decisivo con l’introduzione, dal Codice appalti, dell’obbligo, dal 1° gennaio 2025, di utilizzare il Bim per le gare sopra i due milioni, soglia che scenderà a un milione a partire dal 2026.
Ma cos'è il BIM e quale sarà l’impatto sui professionisti coinvolti?
Vediamo insieme di cosa si tratta, come sta trasformando la professione, quali nuove responsabilità comporta.
BIM: come funziona, cosa dice la norma e come sta ridefinendo le competenze di Architetti e Ingegneri.
Il Building Information Modeling è una metodologia di gestione dei progetti che si basa sull’utilizzo di un modello digitale tridimensionale contenente informazioni integrate relative a geometrie, materiali, costi, tempi, manutenzioni e a tutte le fasi del ciclo di vita dell’opera.
Il suo utilizzo rappresenta un pilastro fondamentale del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici che si fonda su due elementi principali:
-
l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), che consiste in una struttura completamente digitale in cui si sviluppa l’intero ciclo di vita del contratto, semplificando la gestione e le procedure di gara;
-
la Gestione Informativa Digitale (GID), un modello impiegato per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche, che prevede l’uso della metodologia BIM.
Il quadro normativo e l'obbligo di adozione.
L’introduzione del Building Information Modeling (BIM) nelle opere pubbliche ha preso avvio con il Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) ed è stata poi definita attraverso il “Decreto BIM” (d.m. 560/2017), successivamente aggiornato con il d.m. 312/2021.
Questo percorso normativo si è poi consolidato con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) e nel suo correttivo.
L’art. 43 del Codice dei Contratti pubblici (aggiornato dal d.lgs. 209/2024) ha infatti, come anticipato, reso obbligatoria l’adozione della GID da inizio anno per:
-
progetti di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti con un valore stimato superiore a 2 milioni di euro;
-
lavori su beni culturali (ai sensi del d.lgs. 42/2004), qualora l’importo superi i 5.382.000 euro.
Restano esclusi, salvo eccezioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non riguardino opere già digitalizzate.
L’obbligo, inoltre, come chiarito dal Ministero dei trasporti, scatta anche nel caso di completamento di un’opera quando l’importo dei lavori supera la soglia dei 2 milioni di euro.
La normativa ha quindi delle conseguenze dirette per le stazioni appaltanti che devono definire e adottare:
-
un piano di formazione per il personale;
-
un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software BIM;
-
un atto di organizzazione per le procedure di controllo e gestione BIM.
Inoltre, devono nominare:
-
un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE manager);
-
un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi (BIM manager);
-
un coordinatore dei flussi informativi per ogni intervento all’interno della struttura di supporto al RUP (BIM coordinator).
Un aspetto da chiarire è che le stazioni appaltanti possono decidere di adottare il BIM anche nei casi in cui, considerate le caratteristiche del lavoro da eseguire, non è obbligatorio, sfruttando in questo modo i numerosi vantaggi che questa metodologia offre. Tra questi, elenchiamo: la collaborazione multidisciplinare, la riduzione dei costi, la trasparenza.
Nuove funzioni e competenze per Architetti e Ingegneri.
Il BIM, infatti, rende possibile una progettazione realmente collaborativa, dove progettisti, costruttori, committenti e manutentori lavorano insieme all’interno di un unico processo integrato e completamente tracciabile.
Non si tratta solo di modelli tridimensionali, ma di protocolli e regole che richiede la compresenza di diverse figure professionali.
Il cambiamento riguarda quindi anche le aree di competenza dei professionisti, come ingegneri civili e architetti, che vengono coinvoilti in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: valutazione, progettazione, organizzazione e ottimizzazione delle risorse.
Oltre a queste categorie professionali, vengono chiamati nel processo anche ingegneri gestionali, informatici ed esperti di intelligenza artificiale, con il compito di tradurre le esigenze produttive in dati leggibili e modelli predittivi. Ne consegue una ridefinizione dei ruoli che favorisce il dialogo anche tra figure che abitualmente operano in settori separati.
L’impatto di questa nuova metodologia è evidente e testimoniato anche dai numeri: secondo la banca dati Accredia, che raccoglie le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati, in Italia sono oltre 8.200 i profili già certificati come BIM manager, Specialist o Coordinator.
Responsabilità e profilo di richio del professionista.
Sul piano assicurativo questa metodologia non ha introdotto un obbligo assicurativo specifico. Tuttavia, l'introduzione del BIM amplia le aree di competenza, e ridefinisce le funzioni del professionista, modificando di conseguenza, il profilo di rischio.
I ruoli di BIM Manager, Coordinator e Specialist, ad esempio, comportano nuove responsabilità nella gestione e nel controllo dei dati. Le nuove funzioni comportano anche un aumento dei rischi legati alla gestione dei flussi informativi, oltre a una maggiore complessità nella condivisione delle responsabilità tra progettisti, coordinatori, specialisti e committenti.
Allo stesso tempo, la maggiore trasparenza del processo BIM facilita l’individuazione dell’origine di eventuali errori, esponendo maggiormente il professionista responsabile.
In questo contesto, gli intermediari assicurativi hanno un ruolo fondamentale. Devono informare i propri clienti sull’aumento dei rischi derivante dall’adozione del BIM e guidarli nella possibile ridefinizione delle polizze di responsabilità civile professionale.
Questo può comportare, per esempio, la revisione di massimali e limiti di copertura, l’inserimento di estensioni o l’aggiornamento delle clausole relative alla retroattività.
Nonostante quindi, non sia stato definito uno specifico obbligo assicurativo, il contenuto tecnico del rischio professionale coperto sta subendo una profonda evoluzione ed è fondamentale garantire che la polizza rifletta pienamente le nuove responsabilità del professionista.
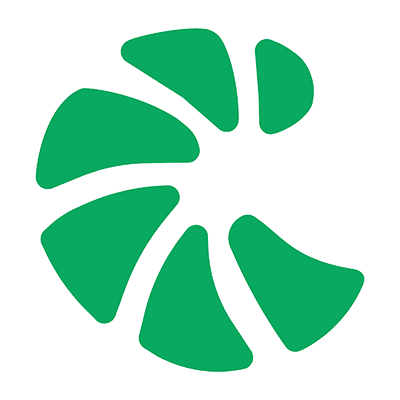
 Rc Professionale
Rc Professionale
 Tutela Legale
Tutela Legale
 Rc Medico
Rc Medico